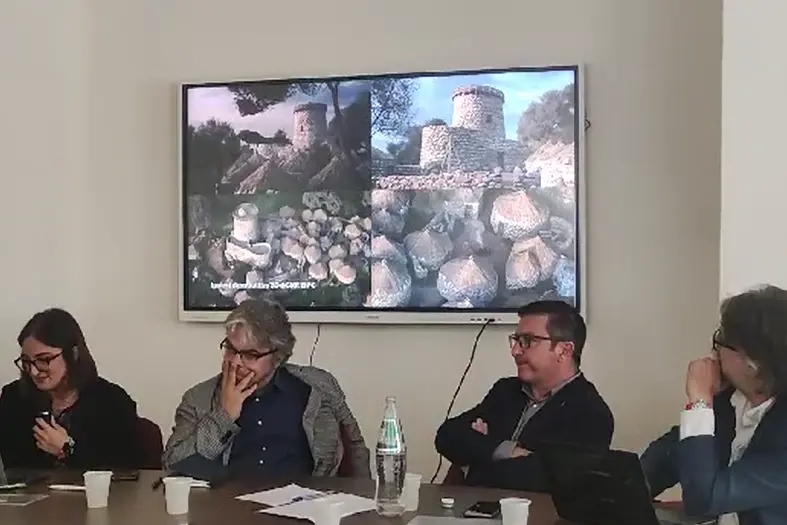Ad Arzachena un mondo da scoprire attraverso i siti archeologici
Continuità anche dal punto di vista genetico tra neolitico ed età del bronzoLuoghi dove un tempo c’era vita, si vivevano ansie, paure, odi, dolori e gioie, nascite e morti; dove si lavorava, lottava, combatteva, mangiava, parlava, dormiva, sognava, soffriva, piangeva, si amava, tradiva, si faceva l’amore, procreava. Dal Fungo al Nuraghe Albucciu, dal Tempietto di Malchittu alla Tomba di Giganti di Coddu ‘Ecchiu, dalla Tomba Moru alla Necropoli Li Muri, dal villaggio nuragico La Prisgiona alla Tomba di Giganti di Li Lolghi; non si tratta dunque, e solamente, di ruderi muti, conci di pietre sovrapposte, frammenti di vasellame ed utensili vari, pervenuti fino a noi, ma testimonianze di un passato lontano, un lasso di tempo enorme, in un’area, quella di Arzachena, piuttosto contenuta ma pericolosamente ed intensamente vissuta da uomini e donne che hanno dato vita a quella che viene considerata una vera e propria “cultura”, quella appunto di Arzachena.
E per quanto riguarda il tempietto di Malchittu, la tomba dei giganti Li Lolghi, il circolo funerario Li Muri e il villaggio nuragico La Prisgiona, con la loro ricostruzione tridimensionale ed interattiva, ha detto appunto Alfonsina Pagano, del CNR, «è possibile ora accedere a contenuti testuali, ad immagini, video, audio, ed esplorare in maniera libera e anche curiosa, quella che era la vita, nell’antichità, tornando indietro nel tempo, a quella che era la vita in questi quattro siti». Stiamo parlando del Neolitico (V millennio a. C., circa il 4.200) fino all'età del Bronzo, quando furono costruiti i primi nuraghi e le tombe di Giganti (II millennio a. C., circa 1.800-1.400).
La presentazione del lavoro del CNR è avvenuta ad Arzachena, oltre che da parte della Pagano, con gli interventi di Augusto Palombini e Giorgio Lucarini. Ma c’è di più. «La preistoria e la protostoria sono poco conosciute e a volte male insegnate, in Italia, rispetto ad altri Paesi come la Francia ad esempio, dove la preistoria è parte integrante di quello che è la coscienza collettiva. La Sardegna è in questo favorita - ha detto l’archeologo Giorgio Lucarini - perché qui abbiamo la possibilità di approfondire i momenti che vengono prima dell’arrivo di quelli che io chiamo le “superpotenze coloniali”, cioè i fenici, i greci e i romani. Ma prima le popolazioni locali chi erano, che cosa facevano?». L’archeologo Lucarini ha ricordato come da un’area che corrisponde all’Anatolia meridionale sia iniziato il processo di neolitizzazione dell’Europa, si sia cioè progressivamente passati «da quelle che erano le economie di caccia, pesca, raccolta, alle prime produzioni di cibo, alle prime comunità agricole e pastorali che poi, attraverso fenomeni migratori, hanno pian piano colonizzato il resto dell’Europa arrivando fino alla penisola iberica e più tardi all’Europa settentrionale». Ebbene, ha proseguito Lucarini, la Sardegna, in questo processo, si trova veramente al centro, «è un po’ l’ombelico del Mediterraneo».
Grazie anche agli studi genetici condotti negli ultimi anni, ha quindi spiegato l’archeologo Lucarini, risulta che «il bagaglio genetico che i sardi hanno, affonda le radici più profonde, proprio durante la fase neolitica». Non solo: «C’è continuità anche durante l’età del bronzo, che quindi rimane anche durante il periodo nuragico». Differentemente da quello che succede in Europa, «in Sardegna tra il neolitico e l’età del bronzo vediamo questa continuità anche dal punto di vista genetico. E quindi quello che voi avete qui, ad Arzachena, rappresenta una finestra, un microcosmo di quello che rappresenta tutta l’Isola».